ROMA, DOVE LA CULTURA...
NEWS > LUGLIO 2025
Roma, dove la Cultura si
intreccia con l’Arte
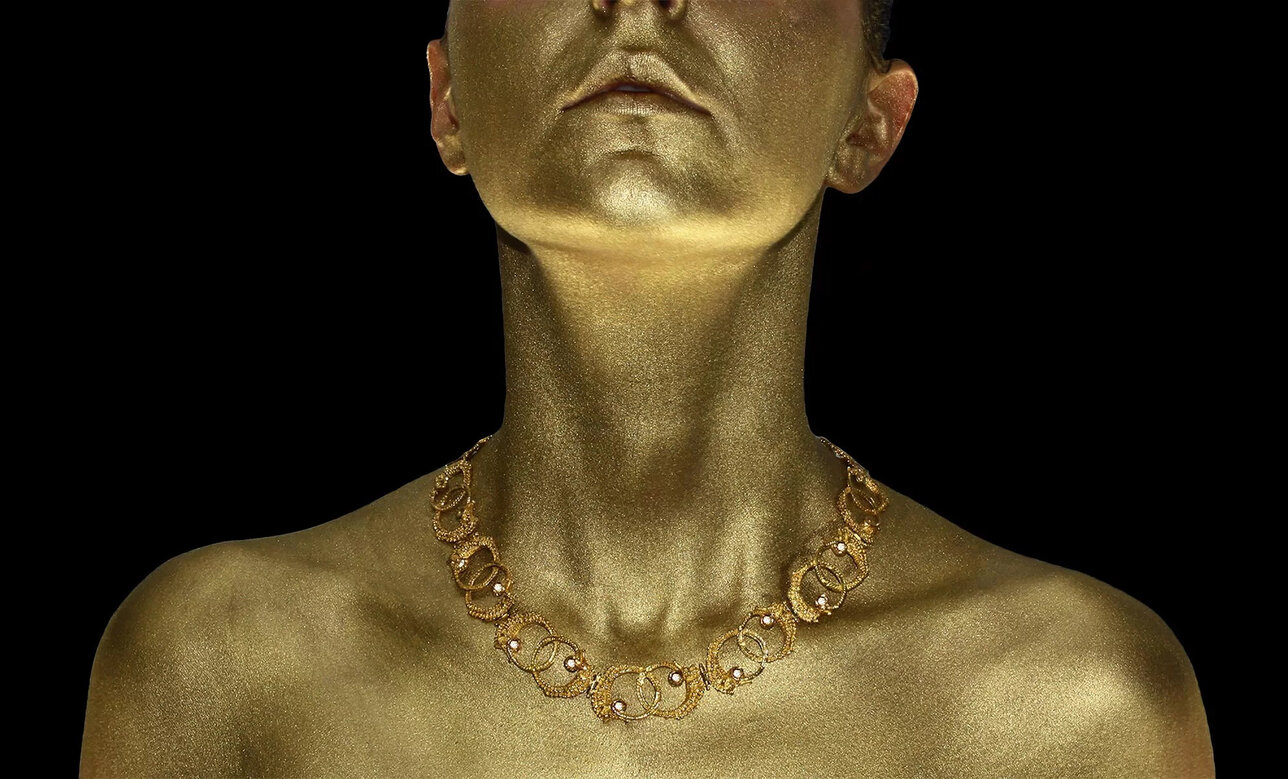
Roma, dove la Cultura si
intreccia con l’Arte e i Gioielli risplendono di storia, nel cuore
pulsante di un autentico “Rinascimento” ottocentesco, nasce nel
1846 una dinastia destinata a lasciare un segno indelebile nell’arte
orafa: la storica casata degli Alfonsi.
Con
Gallo Alfonsi, capostipite di una storica dinastia, prendono forma
opere orafe di straordinario pregio, destinate a Principi, Nobili,
rappresentanti della Santa Sede e ai nuovi Governanti. Un’eredità
artistica che, con il tempo, ha affascinato anche celebrità
provenienti dai mondi più disparati.
Ci
sono luoghi nel mondo noti universalmente per alcuni aspetti, eppure
sorprendentemente ignorati per altri. È il caso di Roma, un tempo
celebrata come Caput Mundi e oggi, secondo molte statistiche,
relegata a posizioni marginali. Ma i numeri non raccontano tutto.
Roma
resta, infatti, un crocevia unico di storia, cultura, arte e memoria
collettiva. Una città che ha visto passare, e spesso nascere,
protagonisti silenziosi della nostra identità culturale. È proprio
qui che hanno mosso i primi passi uomini e famiglie che, pur lontani
dai riflettori, hanno lasciato un’impronta indelebile.
Tra
questi, spicca la famiglia Alfonsi, il cui nome – forse meno noto
al grande pubblico – è sinonimo di eccellenza nell’arte orafa.
Una storia che merita di essere raccontata, perché intreccia
bellezza, tradizione e il genio silenzioso di chi, con le proprie
mani, ha contribuito a scrivere la storia visiva e simbolica del
nostro Paese.
Un
nome che comincia a farsi strada nel cuore pulsante del Risorgimento,
in quel 1846 che segna l’avvio di un’epoca destinata a riscrivere
il volto della penisola italiana. È in questo scenario di fermento e
rinnovamento, durante quella che fu definita la “rivoluzione
italiana” (1815-1871), che emerge la figura di Gallo Alfonsi: un
orafo destinato a lasciare un segno indelebile nella storia dell’arte
orafa italiana.
Il
17 marzo 1861 nacque ufficialmente il Regno d’Italia a Torino, e
nel 1871, con la presa di Roma del 20 settembre 1870, la capitale fu
trasferita nella Città Eterna. Proprio a Roma, nell’atmosfera
intrisa di attese e trasformazioni, Alfonsi inizia la sua carriera
collaborando con il celebre laboratorio de “I Castellani”: una
famiglia di orafi, collezionisti e antiquari che daranno vita a una
vera e propria dinastia artistica tra XIX e XX secolo.
Fondatore
della scuola castellana fu Fortunato Pio Castellani (1794-1865), che
nel 1814 aprì la sua bottega nella capitale. Grazie all’illuminato
sodalizio con il duca Michelangelo Caetani, raffinato disegnatore e
appassionato d’arte, Castellani divenne in breve tempo l’orafo
prediletto dell’aristocrazia romana, e ben presto anche delle élite
europee.
Gallo
Alfonsi, mosso dallo stesso slancio creativo, nel 1850 apre la
propria bottega in via delle Muratte, a due passi dalla Fontana di
Trevi. Lì, nel cuore monumentale di Roma, le sue creazioni d’alta
gioielleria conquistano rapidamente fama e prestigio, distinguendosi
per la raffinatezza dei dettagli e l’equilibrio perfetto tra
tradizione e innovazione.
Il
suo talento non passa inosservato: Alfonsi riesce ad attrarre una
clientela d’élite composta da Principi, Nobili, rappresentanti
della Santa Sede e figure di spicco della nuova classe dirigente di
una Roma ormai capitale d’Italia.
A
suggellare il riconoscimento del suo straordinario valore artistico,
giunge infine la prestigiosa nomina a fornitore ufficiale della Casa
Reale, consacrandolo tra i massimi esponenti dell’arte orafa
italiana del tempo.
La
nascita di Germano Alfonsi, il 30 maggio 1926, segna un nuovo e
luminoso capitolo nella storia della rinomata tradizione orafa della
famiglia Alfonsi. Figlio di Francesco, a sua volta discendente
diretto del capostipite Gallo, Germano eredita un patrimonio di
saperi antichi, ma è la sua visione, unita a un talento fuori dal
comune, a imprimere una svolta decisiva e irripetibile all’arte di
famiglia.
È
proprio Germano, infatti, a condurre la casata orafa verso
un’evoluzione stilistica e tecnica che molti definiscono epocale.
La sua abilità, definita dal critico d’arte Nino D’Antonio come
“straordinaria e prodigiosa manualità che ha fatto parlare di
miracolo”, è al centro del documentario “This is Germano”,
diretto dal regista Daniele Nannuzzi.
Mentre
frequenta gli studi di Architettura, Germano affina il suo linguaggio
artistico sperimentando con il disegno e la modellatura delle cere,
rievocando con naturalezza l’approccio artigianale dei maestri del
Rinascimento. Da questa intimità con la materia nasce un legame
quasi alchemico con la cera, che diventerà la sua firma distintiva e
il punto di forza di uno stile riconoscibile ben oltre i confini
italiani.
Sono
gli anni in cui realizza i suoi primi gioielli: opere di delicata
eleganza, intrise di poesia e rigore formale. Il suo approccio,
improntato a una costante e discreta umiltà, resterà immutato anche
quando il suo nome inizierà a circolare nei salotti più esclusivi,
conquistando una notorietà fondata unicamente sul merito e sul
valore autentico delle sue creazioni.
Alla
morte del padre Francesco, Germano assume la guida dell’attività
di famiglia, imprimendole una nuova direzione. La sua produzione si
arricchisce di piccole sculture in metalli e materiali preziosi, vere
e proprie miniature d’arte che catturano l’attenzione di una
clientela sofisticata ed esigente.
La
storica bottega di via delle Muratte, già vicina alla Fontana di
Trevi, si trasforma in un crocevia di cultura ed eleganza. Non solo
un riferimento per nobili, prelati e aristocratici, ma anche meta
prediletta di esponenti del mondo del cinema, della moda e dello
spettacolo. Sono gli anni della leggendaria “Dolce Vita”, e il
nome di Germano Alfonsi diventa sinonimo di raffinatezza, classe e
saper fare italiano.
È
in quegli anni ruggenti che nomi del calibro di Renato Rascel, Virna
Lisi e Peppino De Filippo diventano frequentatori abituali
dell’atelier Alfonsi, attratti dal magnetismo discreto di un
artista capace di fondere tecnica e anima in ogni sua creazione.
Ma
è nel cuore degli anni Cinquanta che Germano decide di voltare
pagina: lascia la storica sede di via delle Muratte, nel centro
pulsante di Roma, e si trasferisce a Frascati, nei suggestivi
Castelli Romani. Qui apre il suo primo studio in Piazza San Rocco,
per poi trasferirsi in via Ajani, nella sede che diventerà la
celebre “Galleria La Rassegna”, oggi attuale laboratorio orafo.
Gli
anni Sessanta lo consacrano definitivamente come gioielliere d’autore
e scultore dell’anima. È il decennio del leggendario geode di
ametista, opera visionaria in cui scolpisce l’Inferno dantesco:
oltre venti figure di dannati, tra cui Caronte, Paolo e Francesca,
resi con un’accuratezza anatomica e un pathos che non lasciano
spazio all’indifferenza. L’opera attira l’attenzione
internazionale, tanto da essere raccontata anche dal National
Geographic.
Negli
anni Settanta la fama di Germano Alfonsi raggiunge vette
istituzionali. Il Governo italiano gli affida la realizzazione in
miniatura di due fontane simbolo dell’antica Roma: quella del
Tempio di Vesta e quella delle Tartarughe. I due capolavori saranno
donati al presidente sovietico Nikolaj Podgornyj, in un gesto di
diplomazia culturale che suggella l’arte come ponte tra mondi.
Intanto,
il mondo del cinema e del jet set internazionale si fregia dei suoi
monili come di autentici totem di stile. Anna Magnani, Ira von
Fürstenberg, Jacqueline Kennedy, Sophia Loren, Ursula Andress,
Marisa Mell, Antonella Lualdi, Gabriella Ferri, Patty Pravo: tutte
indossano o collezionano le creazioni firmate Alfonsi, riconoscendone
l’eleganza senza tempo e l’unicità formale.
Le
cronache dell’epoca celebrano il suo talento. Il quotidiano IL
TEMPO titola a tutta pagina:
“Si
fa anticamera a Capri per lo scultore Germano”, mentre nuove opere
affascinano il pubblico e la critica: dal Cristo morente destinato a
Papa Giovanni, alle miniature della Pietà e dello Sposalizio della
Vergine ispirate ai capolavori di Raffaello.
A
suggellare questa parabola artistica, arrivano anche le testimonianze
audiovisive e biografiche: il documentario “This is Germano”,
firmato dal regista Daniele Nannuzzi, e la biografia scritta dal
critico d’arte Nino D’Antonio, che restituisce con sensibilità
il ritratto di un uomo e di un artista fuori dal comune.
È
in questo periodo che Germano Alfonsi firma alcune delle sue opere
più iconiche: per la Regione Campania, realizza il gruppo bronzeo
Avanti Insieme, collocato nei giardini del Palazzo Reale di Napoli,
mentre per lo Scià di Persia scolpisce Il Globo, opera poi donata
anche all’allora sindaco di Roma, Walter Veltroni.
Nello
stesso fervido decennio, per la Cattedrale di San Pietro Apostolo di
Frascati, Germano crea la raffinata vetrata della Cappella del SS.
Sacramento, seguita a breve distanza dal monumentale bassorilievo
bronzeo del Paliotto d’altare per la chiesa delle Scuole Pie, una
delle sue prove di maggior prestigio artistico e spirituale.
Gli
anni Ottanta lo consacrano definitivamente sulla scena
internazionale: le sue esposizioni toccano capitali e metropoli
d’arte come New York, San Francisco, Los Angeles, Bruxelles,
Bangkok, Hong Kong e l’Alabama, portando la sua firma ben oltre i
confini nazionali.
Nel
1990, una nuova, solenne creazione: una statua bronzea per la
Basilica di Sant’Alfonso Maria de' Liguori a Pagani, posta su un
basamento in marmo. La scultura raffigura il Santo in vesti
episcopali, colto nell’atto di benedire i suoi fedeli. Un’opera
di grande intensità spirituale che riceve l’alto onore della
benedizione di Papa Giovanni Paolo II.
Ma
il tempo, implacabile, presenta il suo tributo. Una malattia ostinata
costringe Germano a lunghi periodi d’isolamento nella propria
abitazione. Eppure, anche nella sofferenza, l’artista non rinuncia
alla bellezza: trova conforto nel disegno, nella poesia — una
passione segreta che lo ha accompagnato per tutta la vita — fino
alla sua scomparsa, avvenuta a Roma il 4 giugno 2006.
Di
lui scriverà qualcuno: "Germano è l’ultimo discendente di
un’antica stirpe di orafi, autori di celebri manufatti oggi
custoditi nei Musei Vaticani, creatori di architetture sacre e opere
commissionate da nobili casate. La sua straordinaria manualità ha
del miracoloso.”
Le
cronache lo descrivono come un uomo riservato, appartato, quasi
schivo — tratti comuni a chi custodisce dentro di sé l’ardente
fiamma della vera arte. Grande appassionato di pesca e di stampe
antiche, Germano trascorre la sua infanzia tra i banchi del mercato
dei fiori e delle verdure, nel cuore popolare di Roma, tra le donne
con le sporte e i ragazzini che, fino a tarda sera, animano le
vecchie osterie di Campo de’ Fiori.
Con
le mani in tasca, lo sguardo assorto e il passo lento, si perde tra i
banchi fino alla statua del “monaco ribelle”, Giordano Bruno,
figura che da sempre incarna lo spirito inquieto e anticonformista a
lui tanto caro.
Dopo
aver scelto Frascati come rifugio, Roma non è più quella della sua
giovinezza. La quiete ritrovata tra i colli lo consola, ma il legame
con la capitale rimane inciso nell’anima.
Lo
studio di Germano è una contraddizione vivente rispetto alla sua
figura: uno spazio in cui regnano il caos creativo e il disordine
quasi scenografico, simile a un bazar orientale. Argille, cere,
schizzi, monili in argento, strumenti del mestiere, idee appena
abbozzate — un vortice artistico dove ogni opera nasce da un
turbine di intuizioni e dubbi, tra fallimenti e intuizioni geniali. È
lì che germogliano le sue creazioni, lì che la forma trova voce.
Estremamente
severo con sé stesso, Germano si dichiara sempre insoddisfatto del
risultato, superando costantemente i propri limiti, guidato da un
perfezionismo radicato nella sua formazione classica. I suoi numi
tutelari sono i giganti del primo Rinascimento: Michelangelo,
Donatello, e quei valori umanistici che, pur sembrando lontani dai
tempi odierni, continuano a vivere nella sua opera.
Tra
i temi più ricorrenti nelle sue sculture vi è quello delle mani —
simbolo di creazione, di fatica, di umanità — ma anche l’amore,
la solitudine, l’indagine psicologica e il disagio dell’uomo
contemporaneo, imprigionato nei propri limiti.
Le
antiche tradizioni orafe di famiglia sono esaltate dalla sua
creatività fuori dal comune. Le sue creazioni hanno attraversato i
continenti, e c’è sempre qualche celebrità in attesa di ricevere
un suo gioiello. I monili di Germano parlano un linguaggio mitologico
ed etico, ispirati al mondo classico e frutto di anni di studio,
ricerca e passione.
Utilizza
la tecnica millenaria della fusione a cera persa, risalente all’epoca
di Benvenuto Cellini, che ancora oggi rappresenta il cuore pulsante
della produzione artistica della famiglia Alfonsi. Un procedimento
arcaico e affascinante, in cui la cera viene modellata e inglobata in
un cilindro di malta refrattaria. Durante la cottura, la cera si
scioglie, lasciando una cavità che accoglierà l’oro fuso: da
questo processo nascerà l’opera definitiva, irripetibile e intrisa
d’anima.
Oggi
l’eredità artistica di Germano è custodita e proiettata verso il
futuro da Bianca, Francesco e Micaela, suoi figli e nuovi custodi
della tradizione. Ciascun gioiello da loro realizzato è unico,
pensato e plasmato interamente a mano, secondo quella tecnica nobile
e senza tempo che li rende testimoni di un’arte che sfida la
serialità dell’epoca moderna.
“Non
è il materiale prezioso a fare il gioiello — riflettono oggi gli
Alfonsi — ma l’idea che lo anima.”
Parole
che sanciscono il valore profondo della creazione, rendendola eterna.
Non
è un caso, forse, se le più potenti idee si sono spesso manifestate
nel Rinascimento. Così fece Gallo Alfonsi, fondando la sua bottega
nell’Ottocento, nell’Italia che si avviava all’Unità. Così
fece Germano, rivolgendo lo sguardo a quel Rinascimento che fiorì
dopo il buio del Medioevo. E così faranno Bianca e Micaela,
interpreti stilistiche del presente, insieme a Francesco, tecnico
orafo d’eccellenza. Magari affiancati, come accadde con Germano, da
chi possiede quello spirito raro e luminoso che trasforma l’idea in
un’opera unica.
Un’opera
destinata a durare. Preda ambita dei ricchi, dei potenti, degli
intenditori. Ma soprattutto, dono sublime del genio umano.
Ettore Lembo
09/07/2025
